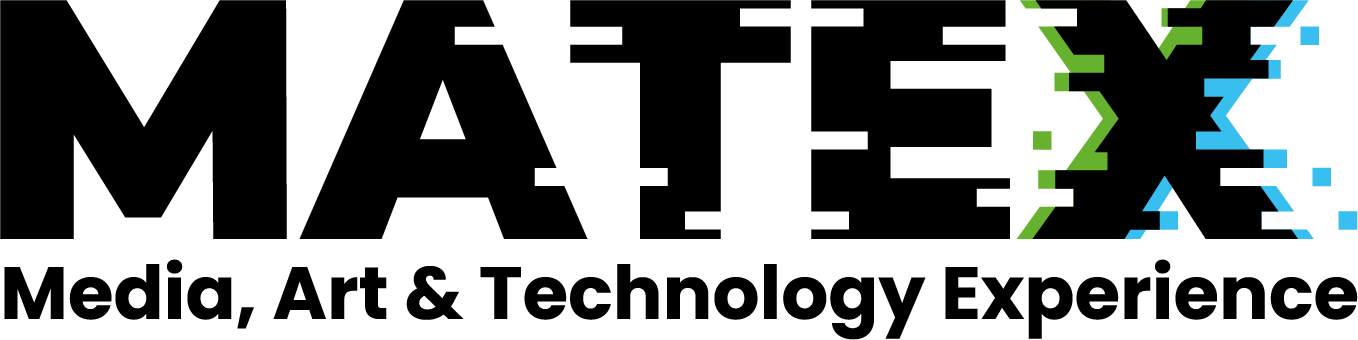Al Jeu de Paume di Parigi va in scena un’esposizione collettiva senza precedenti che affronta in modo critico e strutturato la rivoluzione dell’intelligenza artificiale esplosa a partire dal 2022. Questa data segna l’arrivo di strumenti come ChatGPT e la diffusione massiva di modelli generativi capaci di produrre immagini, testi e video, aprendo un nuovo capitolo nella storia dei media.
La mostra si distingue per un approccio curatoriale che fonde analisi contemporanea e ricostruzione storica. Lungo il percorso espositivo, le “capsule temporali” – vetrine con oggetti d’epoca e materiali d’archivio – guidano il visitatore attraverso un’archeologia dei media. Non si tratta solo di osservare l’oggi, ma di comprenderne le radici, collocando l’IA nella lunga traiettoria delle trasformazioni tecnologiche.
Gli artisti presenti – tra cui Trevor Paglen, Hito Steyerl, Grégory Chatonsky, Kate Crawford, Agnieszka Kurant, Meta Office e molti altri – sono stati scelti attraverso un processo di ricerca partecipativo, alimentato da reti informali, gruppi di discussione e segnalazioni incrociate. In mostra sono presenti opere già note, ma anche produzioni inedite presentate in anteprima, che ampliano lo spettro delle riflessioni in corso.
Una delle sezioni più potenti dell’esposizione riguarda le dimensioni spesso trascurate dell’IA: l’impatto ambientale e lo sfruttamento del lavoro umano. I sistemi di intelligenza artificiale richiedono quantità enormi di energia, minerali rari, acqua. Secondo molte stime, il consumo crescerà vertiginosamente nei prossimi anni, tanto da rendere necessaria la costruzione di nuove centrali energetiche.
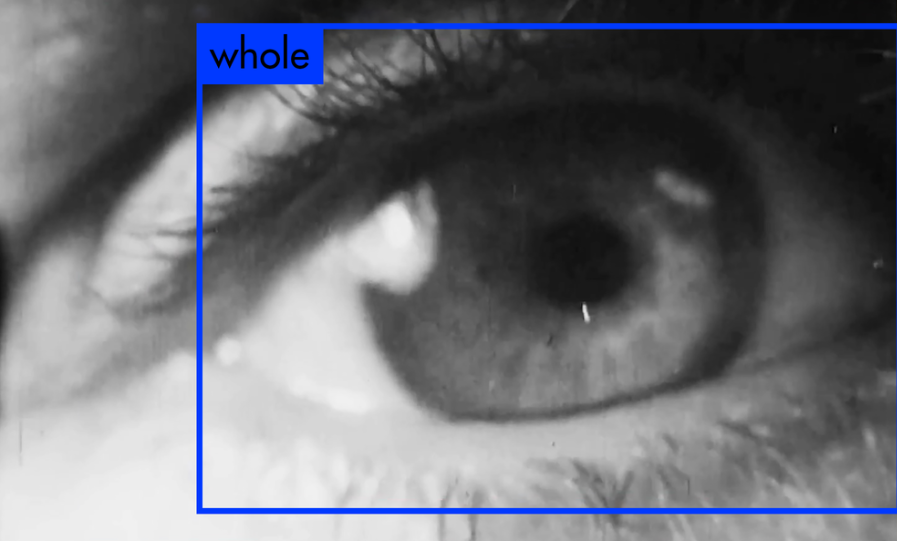
Allo stesso tempo, dietro l’apparente autonomia dei modelli si cela il lavoro invisibile di milioni di “click workers”: individui che moderano contenuti, classificano immagini e addestrano gli algoritmi, spesso per compensi inferiori a due dollari l’ora. L’arte, in questo contesto, si fa portavoce delle voci ignorate e dei costi nascosti di un’innovazione presentata come immateriale.
Particolarmente significativa è l’opera Calculating Empires (2023) di Kate Crawford e Vladan Joler. Questo diagramma monumentale ripercorre la genealogia dell’IA a partire dal Rinascimento, individuando nella scoperta della prospettiva lineare e nella nascita delle griglie geometriche strumenti fondanti del modo in cui oggi si elaborano le immagini. L’arte, insomma, non solo rappresenta, ma costruisce il mondo: anche quello algoritmico.
L’uso dei modelli linguistici nella scrittura ha attraversato una trasformazione profonda. Se i primi esperimenti con sistemi come GPT-2 affascinavano per i loro errori poetici e le “allucinazioni linguistiche”, oggi l’output dei modelli è più fluido, ma anche più prevedibile. La creatività generativa nella letteratura appare in una fase di standardizzazione che riduce l’elemento di sorpresa. Molti artisti scelgono oggi modelli open source e addestramenti personalizzati, nel tentativo di sottrarsi al controllo delle grandi piattaforme.

Confrontarsi con un’intelligenza “altra” spinge l’essere umano a ridefinirsi. È un’occasione di riflessione antropologica: cosa significa pensare, ricordare, creare, in un mondo dove possiamo delegare queste funzioni a una macchina? L’arte, ancora una volta, si pone come spazio di resistenza, interrogazione e reinvenzione dell’umano.
Il futuro dell’IA è incerto persino per chi guida la ricerca tecnologica. Tuttavia, stanno emergendo sistemi “agenti” o “assistenti universali”, in grado di compiere molteplici attività simultaneamente: pianificare viaggi, rispondere a email, acquistare beni. Il loro impatto potrà trasformare radicalmente il lavoro d’ufficio, la produzione di contenuti, l’organizzazione quotidiana.
All’orizzonte si profila anche l’AGI – l’intelligenza artificiale generale – capace, in teoria, di replicare ogni capacità cognitiva umana. Sul piano visivo, si prevede l’arrivo di video generati dall’IA di lunga durata, con narrazioni articolate, interattive e personalizzabili, forse anche da piattaforme di intrattenimento mainstream.
La mostra parigina, più che offrire risposte, intende fornire strumenti per comprendere la complessità del presente. Una cartografia intellettuale e visiva per orientarsi nel paesaggio mutevole dell’intelligenza artificiale. Un progetto che, per la sua profondità e visione, meriterebbe di trovare spazio anche in Italia, in luoghi aperti alla ricerca e alla sperimentazione come la Fondazione Prada.