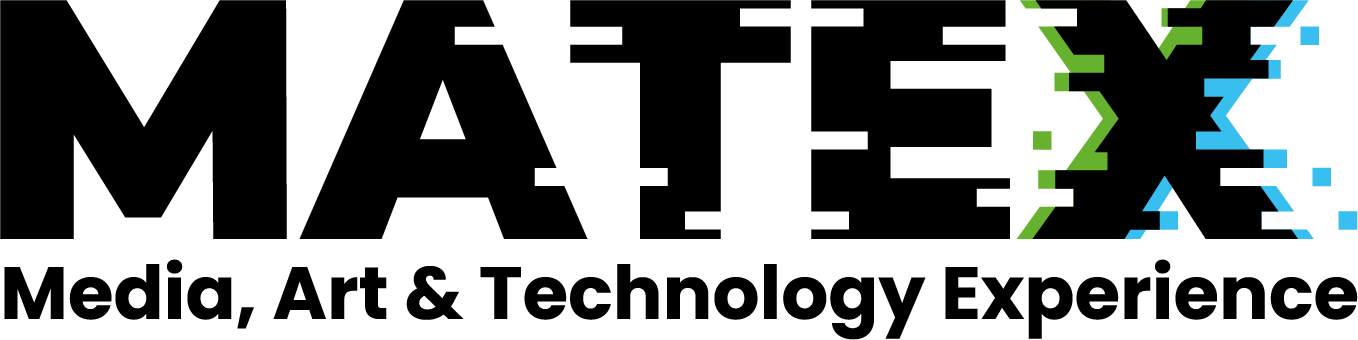(Federica Cannas) – Il 1968 è stato una scossa che ha attraversato l’Europa e il mondo, destinata a cambiare la percezione del potere, della politica e della cultura. I ragazzi che animarono quel movimento nato nelle università non si limitavano a chiedere riforme. Volevano scardinare un intero sistema di valori che ritenevano vecchio, opprimente, incapace di interpretare la modernità.
La loro forza non derivava solo dal bisogno di contestare, ma da un humus culturale e sociale che si era stratificato negli anni precedenti. L’Italia stava vivendo il “miracolo economico”, con un’accelerazione della modernizzazione che metteva a nudo le contraddizioni tra una società proiettata verso i consumi e istituzioni ancora rigide, ancorate al passato. Nelle case arrivavano televisione, elettrodomestici, nuovi modelli di vita, mentre a scuola e in famiglia si respirava ancora un’aria autoritaria, gerarchica, incapace di ascoltare. Questa frattura generava tensione, e i giovani trasformarono quella tensione in motore politico.
La cultura, in quegli anni, era un carburante. I libri di Sartre e Marcuse, le canzoni di protesta, il cinema che rompeva i tabù, i dibattiti infiniti nei caffè e nelle sezioni di partito. Tutto questo preparava un terreno che non poteva rimanere silenzioso.
Quell’energia intellettuale e culturale si traduceva in cortei, manifesti, occupazioni universitarie, discussioni interminabili che spesso si prolungavano per notti intere. Non era solo un agitarsi contro qualcosa, ma il tentativo di inventare linguaggi, simboli e spazi nuovi. L’università, luogo elitario per eccellenza, si trasformava in un laboratorio politico. Era nelle aule occupate che si sperimentava un linguaggio nuovo, capace di intrecciare marxismo, psicoanalisi, utopia libertaria. La cultura era diventata strumento d’azione.
Se c’era una città che condensava tutto lo spirito del ’68, quella era Roma. Gli studenti universitari vivevano immersi in un tessuto urbano vibrante. Il cinema d’autore che rompeva i canoni, i caffè frequentati da artisti, scrittori e registi, le gallerie che ospitavano sperimentazioni radicali. Trastevere era un intreccio di vite, tra artisti bohémien e intellettuali che animavano le notti, mentre Valle Giulia diventava teatro di scontro e discussione. Per i giovani universitari, vivere a Roma significava muoversi in un crocevia di stimoli culturali e politici, respirare un’aria cosmopolita, entrare in contatto con figure di spicco del cinema, della letteratura, della musica. Le strade erano aule parallele, e il confine tra politica e vita quotidiana si faceva sempre più sottile.
Non tutti gli studenti, però, vivevano quell’apertura internazionale nello stesso modo. Poter viaggiare era ancora un privilegio, e le prime esperienze a Londra rappresentavano un’avventura riservata a pochi. La capitale inglese, con la sua Swinging London, i concerti rock e le avanguardie artistiche, era un punto di riferimento che sembrava lontanissimo dalla quotidianità italiana. Chi riusciva a partire tornava con racconti che alimentavano il mito di una gioventù libera, spregiudicata, capace di trasformare la musica e la moda in strumenti di rivoluzione culturale.
Emblematica, in quegli anni, fu anche l’esperienza dei grandi festival. Il concerto all’Isola di Wight, che dal 1968 divenne uno dei più grandi raduni musicali europei, attirò anche ragazzi e ragazze dall’Italia. Non era certo una meta accessibile a tutti, ma per chi vi partecipava si trattava di un rito di passaggio. Il contatto diretto con artisti come Bob Dylan o i grandi del rock angloamericano diventava la conferma che la musica poteva essere politica, protesta, sogno di libertà.
Accanto alle università, le sezioni di partito erano luoghi di confronto e di formazione. Piccole stanze nei quartieri popolari diventavano spazi di discussione accesa, dove si leggevano giornali, si preparavano manifesti e volantini, si discuteva di strategie e utopie. In quegli ambienti la figura di Ernesto Guevara, ucciso in Bolivia nel 1967, divenne subito un mito. Il suo volto con il basco e la stella impresso sulle bandiere e sui muri rappresentava l’idea di rivoluzione possibile, di una gioventù pronta a cambiare il mondo a costo della vita. Per molti studenti italiani, Che Guevara non era solo un simbolo sudamericano, ma il modello di una purezza rivoluzionaria da contrapporre al pragmatismo grigio dei partiti tradizionali.
Non mancavano, però, contraddizioni profonde. Pier Paolo Pasolini, con la sua lucidità spietata, definì il movimento degli studenti come un fenomeno elitario, figlio della borghesia. Scrisse che i veri “figli del popolo” erano i poliziotti schierati contro gli studenti nei cortei, ragazzi delle periferie e delle campagne che non avevano accesso a quell’università trasformata in barricata. La sua posizione scatenò polemiche, ma mise a nudo una verità. Il ‘68 italiano non fu mai del tutto popolare, restò in gran parte espressione di un’élite culturale che parlava in nome di molti, senza però rappresentarli pienamente.
Ma il ’68 non fu solo italiano. Gli studenti guardavano a ciò che accadeva nel mondo. Alle barricate di Parigi, alle proteste contro la guerra in Vietnam, ai movimenti di Berkeley, fino alla Primavera di Praga soffocata dai carri armati sovietici. Era la sensazione di far parte di una rivolta planetaria, di un orizzonte più ampio che univa giovani di Paesi diversi nello stesso sogno di cambiamento.
E dentro quel fermento si muovevano anche le studentesse, che iniziarono a rivendicare un ruolo non più marginale. Nelle assemblee e nelle occupazioni universitarie spesso scoprivano di essere ascoltate meno dei loro compagni maschi. Da lì nacquero le prime discussioni che portarono, negli anni successivi, all’esplosione del femminismo italiano.
Il ‘68 era anche un linguaggio nuovo. Slogan ironici e creativi, murales improvvisati, disegni e volantini che trasformavano le città in una galleria d’arte politica a cielo aperto. Anche il modo di vestirsi, di parlare, di stare insieme diventava dichiarazione politica.
Probabilmente non riuscì a conquistare tutto ciò che si proponeva, e molte delle sue spinte si dispersero negli anni successivi, travolte dalla frammentazione e dalla violenza degli anni Settanta. Eppure lasciò un’eredità profonda. Un nuovo modo di pensare la libertà, la sessualità, i diritti delle donne, la critica al potere e ai consumi. Cambiò per sempre il linguaggio politico e culturale dell’Italia e dell’Europa, aprendo spazi che fino ad allora sembravano impensabili.
(Federica Cannas) – Il 1968 è stato una scossa che ha attraversato l’Europa e il mondo, destinata a cambiare la percezione del potere, della politica e della cultura. I ragazzi che animarono quel movimento nato nelle università non si limitavano a chiedere riforme. Volevano scardinare un intero sistema di valori che ritenevano vecchio, opprimente, incapace di interpretare la modernità.
La loro forza non derivava solo dal bisogno di contestare, ma da un humus culturale e sociale che si era stratificato negli anni precedenti. L’Italia stava vivendo il “miracolo economico”, con un’accelerazione della modernizzazione che metteva a nudo le contraddizioni tra una società proiettata verso i consumi e istituzioni ancora rigide, ancorate al passato. Nelle case arrivavano televisione, elettrodomestici, nuovi modelli di vita, mentre a scuola e in famiglia si respirava ancora un’aria autoritaria, gerarchica, incapace di ascoltare. Questa frattura generava tensione, e i giovani trasformarono quella tensione in motore politico.
La cultura, in quegli anni, era un carburante. I libri di Sartre e Marcuse, le canzoni di protesta, il cinema che rompeva i tabù, i dibattiti infiniti nei caffè e nelle sezioni di partito. Tutto questo preparava un terreno che non poteva rimanere silenzioso.
Quell’energia intellettuale e culturale si traduceva in cortei, manifesti, occupazioni universitarie, discussioni interminabili che spesso si prolungavano per notti intere. Non era solo un agitarsi contro qualcosa, ma il tentativo di inventare linguaggi, simboli e spazi nuovi. L’università, luogo elitario per eccellenza, si trasformava in un laboratorio politico. Era nelle aule occupate che si sperimentava un linguaggio nuovo, capace di intrecciare marxismo, psicoanalisi, utopia libertaria. La cultura era diventata strumento d’azione.
Se c’era una città che condensava tutto lo spirito del ’68, quella era Roma. Gli studenti universitari vivevano immersi in un tessuto urbano vibrante. Il cinema d’autore che rompeva i canoni, i caffè frequentati da artisti, scrittori e registi, le gallerie che ospitavano sperimentazioni radicali. Trastevere era un intreccio di vite, tra artisti bohémien e intellettuali che animavano le notti, mentre Valle Giulia diventava teatro di scontro e discussione. Per i giovani universitari, vivere a Roma significava muoversi in un crocevia di stimoli culturali e politici, respirare un’aria cosmopolita, entrare in contatto con figure di spicco del cinema, della letteratura, della musica. Le strade erano aule parallele, e il confine tra politica e vita quotidiana si faceva sempre più sottile.
Non tutti gli studenti, però, vivevano quell’apertura internazionale nello stesso modo. Poter viaggiare era ancora un privilegio, e le prime esperienze a Londra rappresentavano un’avventura riservata a pochi. La capitale inglese, con la sua Swinging London, i concerti rock e le avanguardie artistiche, era un punto di riferimento che sembrava lontanissimo dalla quotidianità italiana. Chi riusciva a partire tornava con racconti che alimentavano il mito di una gioventù libera, spregiudicata, capace di trasformare la musica e la moda in strumenti di rivoluzione culturale.
Emblematica, in quegli anni, fu anche l’esperienza dei grandi festival. Il concerto all’Isola di Wight, che dal 1968 divenne uno dei più grandi raduni musicali europei, attirò anche ragazzi e ragazze dall’Italia. Non era certo una meta accessibile a tutti, ma per chi vi partecipava si trattava di un rito di passaggio. Il contatto diretto con artisti come Bob Dylan o i grandi del rock angloamericano diventava la conferma che la musica poteva essere politica, protesta, sogno di libertà.
Accanto alle università, le sezioni di partito erano luoghi di confronto e di formazione. Piccole stanze nei quartieri popolari diventavano spazi di discussione accesa, dove si leggevano giornali, si preparavano manifesti e volantini, si discuteva di strategie e utopie. In quegli ambienti la figura di Ernesto Guevara, ucciso in Bolivia nel 1967, divenne subito un mito. Il suo volto con il basco e la stella impresso sulle bandiere e sui muri rappresentava l’idea di rivoluzione possibile, di una gioventù pronta a cambiare il mondo a costo della vita. Per molti studenti italiani, Che Guevara non era solo un simbolo sudamericano, ma il modello di una purezza rivoluzionaria da contrapporre al pragmatismo grigio dei partiti tradizionali.
Non mancavano, però, contraddizioni profonde. Pier Paolo Pasolini, con la sua lucidità spietata, definì il movimento degli studenti come un fenomeno elitario, figlio della borghesia. Scrisse che i veri “figli del popolo” erano i poliziotti schierati contro gli studenti nei cortei, ragazzi delle periferie e delle campagne che non avevano accesso a quell’università trasformata in barricata. La sua posizione scatenò polemiche, ma mise a nudo una verità. Il ‘68 italiano non fu mai del tutto popolare, restò in gran parte espressione di un’élite culturale che parlava in nome di molti, senza però rappresentarli pienamente.
Ma il ’68 non fu solo italiano. Gli studenti guardavano a ciò che accadeva nel mondo. Alle barricate di Parigi, alle proteste contro la guerra in Vietnam, ai movimenti di Berkeley, fino alla Primavera di Praga soffocata dai carri armati sovietici. Era la sensazione di far parte di una rivolta planetaria, di un orizzonte più ampio che univa giovani di Paesi diversi nello stesso sogno di cambiamento.
E dentro quel fermento si muovevano anche le studentesse, che iniziarono a rivendicare un ruolo non più marginale. Nelle assemblee e nelle occupazioni universitarie spesso scoprivano di essere ascoltate meno dei loro compagni maschi. Da lì nacquero le prime discussioni che portarono, negli anni successivi, all’esplosione del femminismo italiano.
Il ‘68 era anche un linguaggio nuovo. Slogan ironici e creativi, murales improvvisati, disegni e volantini che trasformavano le città in una galleria d’arte politica a cielo aperto. Anche il modo di vestirsi, di parlare, di stare insieme diventava dichiarazione politica.
Probabilmente non riuscì a conquistare tutto ciò che si proponeva, e molte delle sue spinte si dispersero negli anni successivi, travolte dalla frammentazione e dalla violenza degli anni Settanta. Eppure lasciò un’eredità profonda. Un nuovo modo di pensare la libertà, la sessualità, i diritti delle donne, la critica al potere e ai consumi. Cambiò per sempre il linguaggio politico e culturale dell’Italia e dell’Europa, aprendo spazi che fino ad allora sembravano impensabili.