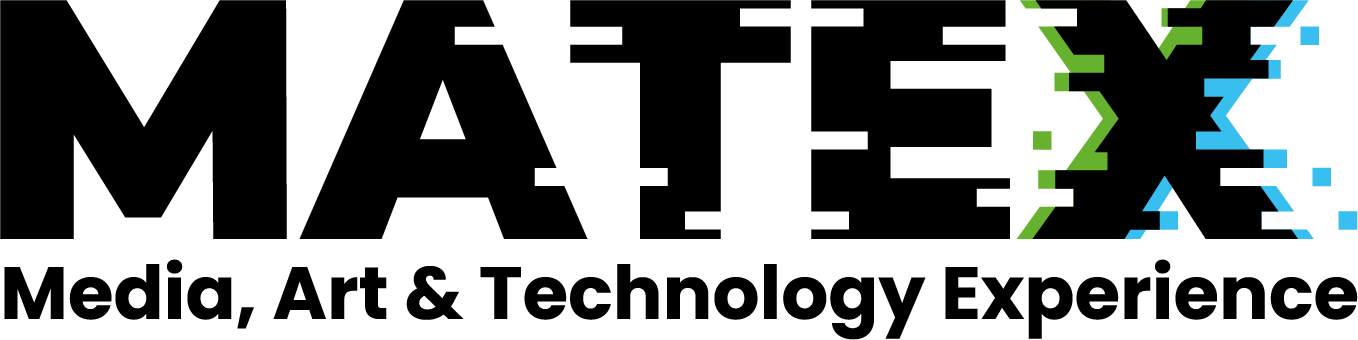(Virginia Nicoletti) – Si è da poco conclusa la tournée italiana di “The Book of Mormon”,il controverso musical vincitore di 30 premi internazionali, che nelle scorse settimane ha fatto tappa presso il Teatro Arcimboldi di Milano, con una produzione composta da artisti di altissimo valore e grande capacità scenica, una orchestra impeccabile, e una messa in scena generale degna davvero dei migliori teatri mondiali.
Data la mia (ormai più volte) dichiarata passione per i musical, soprattutto se in lingua originale, non ho ovviamente perso l’occasione per gustarmi questo famosissimo show.
La storia di questo spettacolo comincia all’inizio degli anni Duemila, quando Trey Parker e Matt Stone, già famosi per l’umorismo scorretto e politicamente esplosivo di “South Park”, vanno a vedere “Avenue Q”, il musical con pupazzi di Robert Lopez e Jeff Marx, che prende in giro il musical stesso e certi miti americani. Lì scoprono una sintonia inattesa, dato che tutti e quattro hanno la stessa fissazione, ovvero il raccontare in modo comico e spregiudicato la figura di Joseph Smith, fondatore della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni, e il libro sacro su cui si basa questa fede, <il libro di Mormon>.
L’incontro fra l’irriverenza dissacrante di Parker e Stone e l’abilità teatrale di Lopez (Marx abbandonerà subito l’idea), finisce per dar vita ad un progetto che non nasce in laboratorio, ma a strappi, fra un impegno e l’altro, con riunioni a cavallo tra Los Angeles, New York e Londra. Nel 2003 Parker, Stone e Lopez fanno persino un viaggio a Salt Lake City nello Utah, cuore simbolico del mormonismo, durante il quale osservano come la religione si intrecci alla quotidianità, accumulando materiale per una storia che vuole essere allo stesso tempo blasfema e curiosamente rispettosa.
Dopo anni di scrittura a singhiozzo, workshop, prove e riscritture, al debutto a Broadway, nel 2011, “The Book of Mormon” spiazza tutti. Contrariamente alle aspettative (molti credevano sarebbe stato solo una lunga “puntata di South Park con canzoni”) il risultato di questo stravagante connubio professionale è un vero musical – classicissimo nella struttura, con numeri corali, balli coreografati e melodie che restano in testa, a cominciare da “Hallo” – in cui la storia dei giovani missionari mormoni è proposta in forma di satira musicale feroce ma, sorprendentemente, piena di tenerezza umana, in un equilibrio quasi miracoloso tra oscenità e dolcezza, qualità riconosciuta anche dalla stampa statunitense (solitamente caustica).
Il resto è cronaca di un fenomeno: il musical fa il pieno di premi, tra cui nove Tony Awards (gli “Oscar del teatro”), e le repliche si susseguono per anni a Broadway, per poi conquistare il West End londinese con lo stesso entusiasmo di pubblico e critica.
Sul palcoscenico il cuore della narrazione è rappresentato dal viaggio iniziatico di due giovani mormoni, pronti a partire per la loro missione biennale di evangelizzazione – rito di passaggio per tanti ragazzi della Chiesa – che vengono proiettati in un villaggio ugandese, rappresentato in modo volutamente eccessivo e quasi grottesco, pieno di ferite, malattie, violenza e sogni testardi, dove la fede, vera o inventata, diventa un modo per sopravvivere al caos del mondo.
Tra l’ilarità del pubblico che non riesce a trattenere le risate per le innumerevoli battute e gli esilaranti doppi sensi, in scena si susseguono “le avventure” di Elder Kevin Price, che è il prototipo del “golden boy” religioso – carino, sicuro di sé, convinto di essere destinato a grandi cose – e del suo “opposto” Elder Arnold Cunningham, goffo, insicuro, bugiardo compulsivo – uno che trova rifugio nei film e nei fumetti e che non ha mai imparato davvero a distinguere la fantasia dalla realtà –
Figli delle loro stesse contraddizioni, i due tentano di portare a termine la loro missione religiosa in un vortice di eresia creativa in cui Cunningham mescola l’iconografia mormone con emblemi della cultura pop, facendo così affiorare, tanto negli spettatori credenti quanto in quelli scettici, alcune domande: fino a che punto abbiamo bisogno delle storie, e cosa siamo disposti ad accettare – o inventare – pur di credere che il mondo abbia ancora un senso? E se una storia è falsa ma fa del bene e rende più sopportabile l’insopportabile, è meno accettabile di una storia vera che non consola nessuno?
Nonostante le scuole di pensiero ridotte a gag, l’attacco al proselitismo ingenuo e la blasfemia dichiarata, “The Book of Mormon”, con il suo linguaggio sboccato, restituisce un’immagine dei mormoni ambivalente. In una modalità apertamente satirica e caricaturale mostra sia il lato ingenuo, dogmatico e “assurdo” della loro dottrina, sia la forza “umana” della fede come strumento di speranza.
Comunque, a chi non l’ha visto posso solo dire: <abbiate fede, e alla prossima occasione non perdetevelo!>.