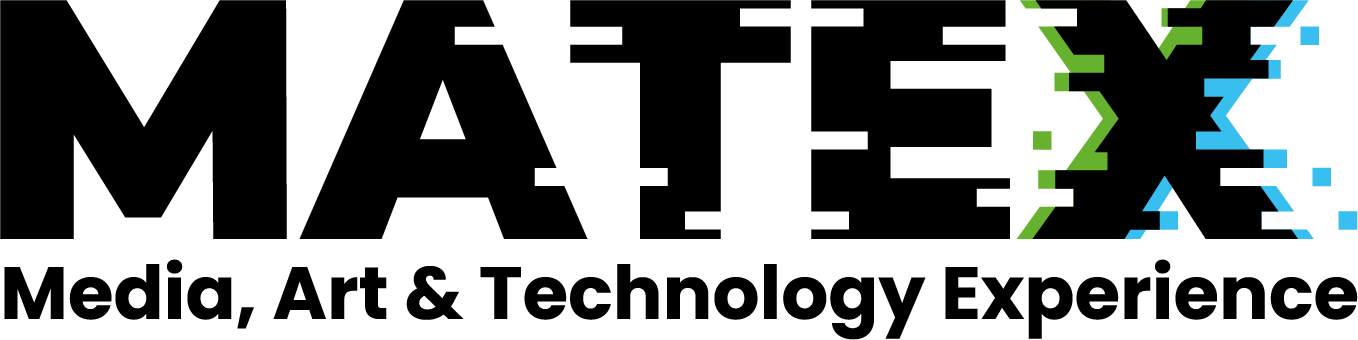di Virginia Nicoletti
In questi giorni ci ha lasciato Valentino Garavani, “l’ultimo imperatore” – cioè l’ultima grande figura di haute couture intesa in senso classico -: un couturier circondato da un vero “regno” fatto di rituali, lusso, muse e spettacolarità, in un’epoca in cui la moda è diventata soprattutto industria.
Proprio la sua figura, al confine tra mito personale e sistema economico, mostra come la moda non sia solo un’attività applicata, commerciale, effimera e funzionale al corpo, ma anche un fenomeno sociale e una pratica estetica capace di esprimere contenuti simbolici e narrativi, dotata di piena dignità artistica in molti suoi esiti.
Nel momento in cui gli abiti hanno smesso di essere solo “qualcosa da mettersi”, e si sono evoluti nella trasposizione di un pensiero, di un’emozione, di un’intuizione la cui forma visiva non si esaurisce nella loro funzione pratica – e le collezioni hanno cominciato a mettere in discussione le tendenze, spingendole un po’ più in là e aprendo uno spazio nuovo nello sguardo di chi guarda -, la moda si è rivelata per ciò che può essere davvero, ovvero una forma d’arte.
I couturier sono come artisti che osservano il proprio tempo, ne raccolgono i segnali più sottili e li restituiscono trasformati, stagione dopo stagione, costruendo un “mondo” fatto di stoffe e fili, in un processo creativo simile a quello delle altre arti visive (con il corpo come supporto).
Dentro questo racconto, spicca la generazione di couturier che ha costruito il mito del Made in Italy, che somiglia a una costellazione di personaggi quasi romanzeschi, ognuno con il proprio tono, la propria ossessione, il proprio modo personale di trasformare il tessuto in visione. Tra questi, naturalmente, Valentino – il grande narratore del sogno, colui che ha trasformato la couture in un teatro dell’emozione -, Armani – che ha tolto il rumore in eccesso dall’abito per lasciare parlare la linea -, Missoni – che ha rivoluzionato la maglieria, componendo vere e proprie “partiture” di colori, specchio di un’Italia creativa e luminosa -, Gucci – che ha trasformato il lusso in un linguaggio fatto di simboli, citazioni e ironia –. Accanto a loro un gran numero di altri talenti – Versace, Prada, Dolce & Gabbana, per citarne alcuni – artefici anch’essi di una maniera di intendere la bellezza, il corpo, il tempo, che ha cambiato per sempre il modo in cui il genere umano si veste e si immagina davanti allo specchio.
Alcuni stilisti (come Schiaparelli, Ferragamo, Capucci, Schuberth, e molti altri) hanno lavorato in dialogo esplicito con la pittura e la scultura, creando abiti ispirati a colonne doriche, Dalì, Pollock, Mondrian, Klimt, Burri ecc., diventati pezzi da collezione, al pari delle altre opere d’arte. Entrati nei musei un po’ alla volta, dapprima timidamente, come testimoni di costume, gli abiti si sono poi imposti con forza, da protagonisti.
Nel tempo sono nati progetti di maison universalmente rinomate, in cui prendono forma installazioni con abiti sospesi, ambienti immersivi, bozzetti e prove in tela accostati alle creazioni finite, quasi a invitare il visitatore a seguire la mano del designer come seguirebbe quella di un pittore, dal primo segno incerto alla forma definitiva. In tutti questi luoghi l’abito appare come il frammento di una storia più grande, il pezzo di una narrazione che parla tanto dell’epoca in cui ha visto la luce, quanto del singolo creatore.
Ciò che rende unica la moda come forma d’arte, è il non pretendere silenzio e distanza quanto, piuttosto, complicità. È un fenomeno sociale in cui le “opere” – figlie di un linguaggio che si infila nelle pieghe della vita quotidiana e le illumina – vivono, si lasciano toccare, invecchiano insieme a chi le fruisce. E di chi le indossa raccontano molto: appartenenze sociali, valori, aspirazioni, differenze generazionali.
Gli studi sul rapporto che lega moda e identità insistono sul ruolo che i vestiti possono assumere nel raccontarci, a noi stessi e al mondo, in quell’ambivalenza tra desiderio di somigliare agli altri e bisogno di affermare una differenza.
Così, nelle strade delle città, sulle passerelle improvvisate dei marciapiedi, nelle immagini che scorrono sui telefoni, va in scena una sorta di grande installazione collettiva composta da migliaia di corpi vestiti in modo diverso.
In questa rappresentazione sociale, la moda rivela allora la sua natura più profonda di dispositivo sensibile che traduce il tempo in forme, intrecciando biografie individuali e immaginario comune. Riconoscere alla moda una piena dignità artistica significa riconoscere che anche ciò che indossiamo – nei musei come nelle strade – è parte integrante del modo in cui una società pensa, sente e mette in scena se stessa.