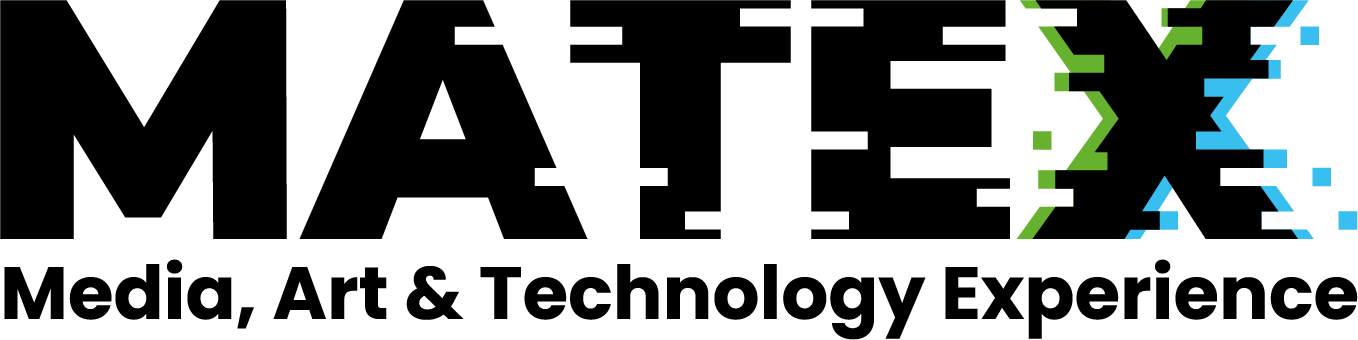di Virginia Nicoletti
Ricorre quest’anno il quarantacinquesimo anniversario di “CATS”, il musical dei record firmato da Andrew Lloyd Webber, che nei giorni scorsi ha concluso la sua tournée in Italia, con una serie di spettacoli al Teatro Arcimboldi di Milano.
La storia è ambientata nel celebre “junkyard” abitato dai “Jellicle Cats”: una notte all’anno la tribù felina si riunisce per raccontare le proprie storie in una girandola di numeri corali, assoli acrobatici e l’attesa dell’elezione del gatto destinato a una nuova vita, sostenuta da una partitura che intreccia brani ritmati e momenti più lirici, fino a “Memory”, il canto di Grizabella.
La produzione che è andata in scena ha rappresentato un’occasione rara per il pubblico italiano, perché cast e allestimento riprendono la tradizione del West End (partitura di Lloyd Webber e drammaturgia a quadri identiche all’originale, versione in inglese, coreografie serrate, orchestra dal vivo, scenografia che avvolge platea e palcoscenico, con un primo numero talmente lungo e complesso da richiedere il blocco dell’ingresso ai ritardatari per quasi venti minuti) proponendola però con una nota di “freschezza” – che ho percepito durante la rappresentazione a cui ho avuto il piacere di assistere – che non nasce da aggiornamenti di trama o da interventi di riscrittura, ma dalla capacità di una macchina scenica collaudata di rigenerare un meccanismo narrativo ritualmente semplice e abbastanza elastico da adattarsi a sensibilità diverse, attraverso corpi, voci e occhi nuovi (con “Memory” cantata e agita come un ricordo ancora bruciante), mantenendo integro il nucleo fatto di musica, danza, e quella strana, ostinata, poesia felina, cardine emotivo di “CATS”.
Quando “CATS” debutta al New London Theatre nel 1981, nessuno può prevedere che diventerà uno dei musical più longevi del West End e di Broadway. L’idea stessa di costruire uno spettacolo a partire dalle poesie di “Old Possum’s Book of Practical Cats” di T. S. Eliot sembrava, sulla carta, un esperimento rischioso: non c’era una trama tradizionale, solo una galleria di gatti eccentrici, ritratti in versi ironici e sottilmente malinconici.
Lloyd Webber, reduce dai successi di “Jesus Christ Superstar” ed “Evita”, decide di dare la forma di un “teatro totale” al progetto, in cui musica, danza e scenografia sono indissolubili, e la narrazione emerge per frammenti, più atmosferica che lineare. Grazie a Trevor Nunn alla regia e Gillian Lynne alla coreografia, il miracolo viene compiuto.
Il pubblico risponde entusiasta. Lo spettacolo resta ventun anni in scena a Londra con quasi novemila repliche, consacrato dagli Olivier e dagli Evening Standard Awards come miglior musical, conquistando Broadway nel 1983 grazie ad una campagna di lancio colossale, sette Tony Awards, e diciotto anni di repliche, che lo portano a diventare, a metà anni Novanta, il musical più longevo nella storia della Great White Way, con produzioni che si estendono in tutto il mondo.
Gli ingredienti che “CATS” porta al massimo grado sono quelli tipici del marchio Lloyd Webber: melodie immediatamente riconoscibili, almeno una canzone destinata a vivere fuori dal contesto teatrale, un impianto spettacolare che punta sull’impatto visivo, una struttura che privilegia l’emozione diretta rispetto alla complessità narrativa dei musical che l’hanno preceduto, una gestione quasi imprenditoriale della durata, dei tour e delle licenze internazionali. In questo senso, l’anniversario di “CATS” è un’opportunità per misurare la distanza fra gli anni della nascita del mega-musical e l’oggi, in cui il teatro musicale convive con linguaggi diversissimi, dal rap alla sperimentazione più intimista. Il fatto, comunque, che in occasione di questa ricorrenza sia stato rilanciato in forma rinnovata, invece di limitarsi a un concerto celebrativo o a un documentario commemorativo, suggerisce che quest’opera viene ancora percepita come materia viva, capace di reggere la prova del presente.
Alla fine, quello che resta di questa nuova notte “Jellicle” non è, secondo me, tanto l’effetto speciale o il numero più applaudito, ma la sensazione di essersi seduti accanto a una tribù che esiste da sempre e ogni volta trova un modo diverso per raccontarsi, fin dal suo primo miagolio.