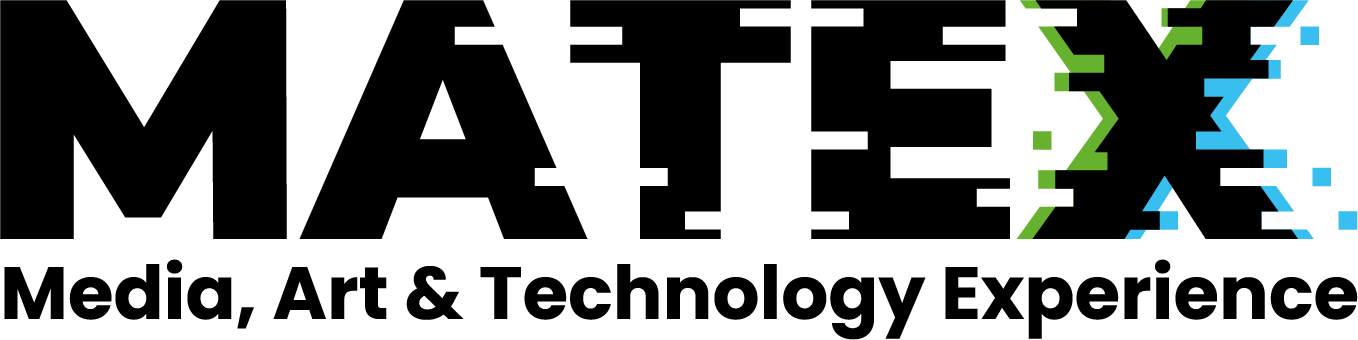(Federica Cannas) Vive in un appartamento londinese troppo piccolo per i suoi sogni e troppo grande per i suoi fantasmi. Si chiama Dylan Dog, e da quasi quarant’anni co racconta che la vera avventura non è uccidere mostri, ma riconoscerli dentro di noi.
Quando Tiziano Sclavi lo crea nel 1986, il fumetto italiano è ancora dominato da eroi granitici, infallibili, spesso immersi in storie avventurose con un lieto fine ben definito. Dylan è l’opposto. Un investigatore privato che non porta pistole, che soffre di paure e malinconie, che non riesce a mantenere una relazione sentimentale. Un uomo che si lascia attraversare dagli incubi degli altri e, inevitabilmente, anche dai propri.
Il suo mestiere è quello di indagare sul soprannaturale, ma la verità è che non indaga mai solo sui fantasmi. Indaga sull’ombra della solitudine, sull’angoscia della morte, sul labirinto della mente umana. Zombie, vampiri, mostri sono metafore, incarnazioni di paure collettive e personali. In questo sta la sua forza. Dylan Dog combatte per capire.
Ogni storia mescola citazioni, rimandi, frammenti che spaziano dal gotico alla filosofia, dal cinema all’arte. È come se Sclavi avesse voluto costruire un personaggio che fosse più di un fumetto. Contenitore di inquietudini universali, travestite da racconto dell’orrore. Dylan Dog vive le storie come un testimone fragile, spesso impotente, ma sempre capace di lasciarsi ferire.
E forse è proprio questa vulnerabilità a renderlo immortale. Dylan Dog ci insegna a convivere con le paure. Ci accompagna dentro il buio con la lanterna della sua malinconia. Lontano dagli eroi che vincono, lui resta in piedi nonostante la sconfitta. La sua forza è mostrare la fragilità.
Non è un caso che le sue storie raramente si chiudano con un trionfo. Spesso lasciano un senso di sospensione, un dubbio, una ferita aperta. Dylan Dog non è l’eroe della risoluzione. È l’eroe che ci dice che il male si riconosce, si affronta, a volte lo si accetta.
Attorno a lui ruotano figure che accentuano questa fragilità: Groucho, con la sua comicità surreale, che spezza la tensione e rivela il paradosso della vita; Bloch, padre e mentore, simbolo di una generazione stanca ma ancora presente; le infinite donne amate e perdute, che incarnano l’impossibilità di afferrare davvero la felicità. Tutto, nella vita di Dylan, è transitorio, eppure intenso.
Molti lettori hanno trovato in lui uno specchio delle proprie inquietudini adolescenziali o adulte. Dylan Dog ha parlato a chi si è sentito diverso, a chi ha avuto paura di non essere abbastanza forte.
Oggi, mentre gli eroi al cinema tornano a essere iper perfetti, Dylan Dog resta un antidoto. La sua vera arma è la capacità di ascoltare i propri incubi e quelli degli altri.
Un investigatore che inciampa, che soffre, che ama senza riuscire a tenere stretta nessuna felicità. In fondo, l’unico vero eroe possibile in un mondo come il nostro.
Quando Tiziano Sclavi lo crea nel 1986, il fumetto italiano è ancora dominato da eroi granitici, infallibili, spesso immersi in storie avventurose con un lieto fine ben definito. Dylan è l’opposto. Un investigatore privato che non porta pistole, che soffre di paure e malinconie, che non riesce a mantenere una relazione sentimentale. Un uomo che si lascia attraversare dagli incubi degli altri e, inevitabilmente, anche dai propri.
Il suo mestiere è quello di indagare sul soprannaturale, ma la verità è che non indaga mai solo sui fantasmi. Indaga sull’ombra della solitudine, sull’angoscia della morte, sul labirinto della mente umana. Zombie, vampiri, mostri sono metafore, incarnazioni di paure collettive e personali. In questo sta la sua forza. Dylan Dog combatte per capire.
Ogni storia mescola citazioni, rimandi, frammenti che spaziano dal gotico alla filosofia, dal cinema all’arte. È come se Sclavi avesse voluto costruire un personaggio che fosse più di un fumetto. Contenitore di inquietudini universali, travestite da racconto dell’orrore. Dylan Dog vive le storie come un testimone fragile, spesso impotente, ma sempre capace di lasciarsi ferire.
E forse è proprio questa vulnerabilità a renderlo immortale. Dylan Dog ci insegna a convivere con le paure. Ci accompagna dentro il buio con la lanterna della sua malinconia. Lontano dagli eroi che vincono, lui resta in piedi nonostante la sconfitta. La sua forza è mostrare la fragilità.
Non è un caso che le sue storie raramente si chiudano con un trionfo. Spesso lasciano un senso di sospensione, un dubbio, una ferita aperta. Dylan Dog non è l’eroe della risoluzione. È l’eroe che ci dice che il male si riconosce, si affronta, a volte lo si accetta.
Attorno a lui ruotano figure che accentuano questa fragilità: Groucho, con la sua comicità surreale, che spezza la tensione e rivela il paradosso della vita; Bloch, padre e mentore, simbolo di una generazione stanca ma ancora presente; le infinite donne amate e perdute, che incarnano l’impossibilità di afferrare davvero la felicità. Tutto, nella vita di Dylan, è transitorio, eppure intenso.
Molti lettori hanno trovato in lui uno specchio delle proprie inquietudini adolescenziali o adulte. Dylan Dog ha parlato a chi si è sentito diverso, a chi ha avuto paura di non essere abbastanza forte.
Oggi, mentre gli eroi al cinema tornano a essere iper perfetti, Dylan Dog resta un antidoto. La sua vera arma è la capacità di ascoltare i propri incubi e quelli degli altri.
Un investigatore che inciampa, che soffre, che ama senza riuscire a tenere stretta nessuna felicità. In fondo, l’unico vero eroe possibile in un mondo come il nostro.