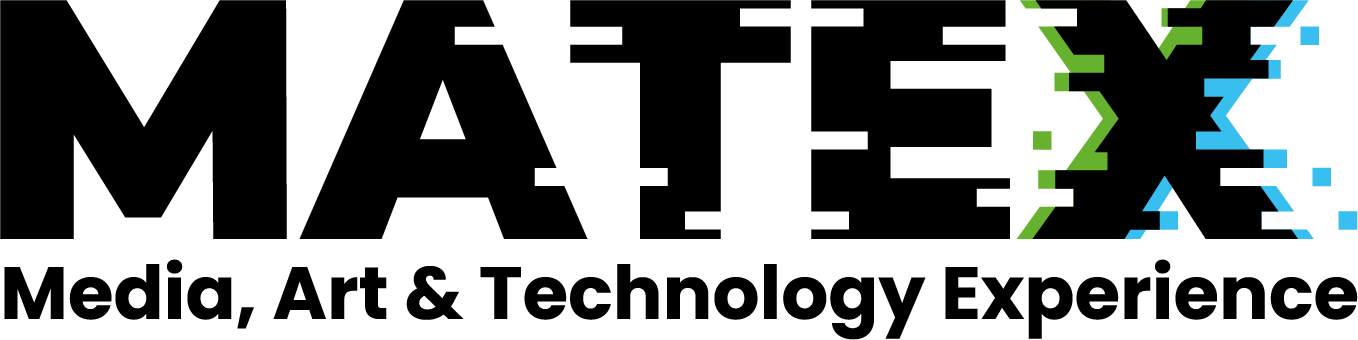(Federica Cannas) – L’opera di Julio Cortázar è un continuo esperimento, un gioco di specchi in cui la realtà e il sogno si confondono e in cui il lettore non è mai semplice spettatore, ma è chiamato a partecipare attivamente.
Nato a Bruxelles nel 1914 da genitori argentini e cresciuto a Buenos Aires, Cortázar scelse Parigi come sua patria adottiva, ma portò sempre dentro di sé il ritmo, le ferite e le speranze del Sudamerica. È proprio da questa doppia appartenenza che nasce la sua originalità. Da un lato la profondità della cultura europea, dall’altro la vitalità e l’immaginazione sudamericana. Due anime che si intrecciano e che fanno della sua scrittura un linguaggio unico.
Il libro che più di ogni altro ha segnato la storia della letteratura è Rayuela. Il gioco del mondo (1963). Non è un romanzo tradizionale, ma un labirinto narrativo, un esperimento. Cortázar lo concepì come un testo a più ingressi, un’opera che si può leggere in ordine lineare, dall’inizio alla fine, oppure saltando da un capitolo all’altro seguendo uno schema suggerito dall’autore stesso. Come in un gioco, il lettore sceglie il percorso, e ogni volta la storia cambia.
Rayuela spinge a ripensare la letteratura. Non più una strada già tracciata, ma un viaggio che dipende dalle scelte di chi legge. Con questo romanzo Cortázar ha infranto il patto tradizionale tra autore e lettore. Ha aperto uno spazio in cui la parola e la narrazione diventano esperienza condivisa. È stato un gesto di rottura, che ha ispirato generazioni di scrittori e che ancora oggi conserva tutta la sua modernità.
Se Rayuela ha innovato, sono i racconti ad aver fatto di Cortázar un maestro della forma breve e mostrano il suo talento nel trasformare l’ordinario in straordinario.
Un esempio è Le bave del diavolo, un racconto in cui un fotografo crede di aver catturato con la macchina fotografica un dettaglio insignificante, ma che si rivela carico di significati nascosti, fino a sconvolgere la sua percezione della realtà. Michelangelo Antonioni ne trasse ispirazione per Blow-Up(1966), film che divenne manifesto della modernità negli anni Sessanta. Attraverso quella storia, Cortázar aveva già intuito che ciò che crediamo di vedere non è mai tutta la verità, che ogni immagine, ogni frammento di vita, può contenere un enigma.
Dietro l’innovatore letterario, c’era anche un uomo profondamente legato alla sua terra. Pur vivendo a Parigi, Cortázar non smise mai di sentirsi parte del destino del Sudamerica. Seguì con passione le rivoluzioni del suo tempo, si schierò con Fidel Castro e Cuba e con il Nicaragua sandinista, si fece voce solidale dei popoli in lotta contro le dittature e l’imperialismo. Fu osservatore critico e partecipe, capace di mettere la sua intelligenza al servizio delle cause che riteneva giuste.
La sua scrittura, per quanto cosmopolita, porta dentro il ritmo e la malinconia di Buenos Aires, il tango, le notti lunghe e piene di ombre. C’è sempre, nei suoi testi, il legame con quella dimensione latinoamericana fatta di contraddizioni, di speranza e di dolore.
Leggere Cortázar significa lasciarsi trascinare in un territorio senza confini. I suoi testi non sono mai univoci, aprono possibilità, moltiplicano prospettive, invitano a non accontentarsi della superficie. Dentro c’è il jazz, con le sue improvvisazioni, ci sono gli scacchi, con le loro mosse impreviste, ci sono i sogni, c’è l’amore, c’è la politica.
Julio Cortázar ha fatto della scrittura un gioco infinito e della letteratura una sfida alla realtà. Per questo, a più di quarant’anni dalla sua morte, è una voce attuale che conferma quanto leggere sia un’avventura, un atto di libertà, un salto dentro l’ignoto.