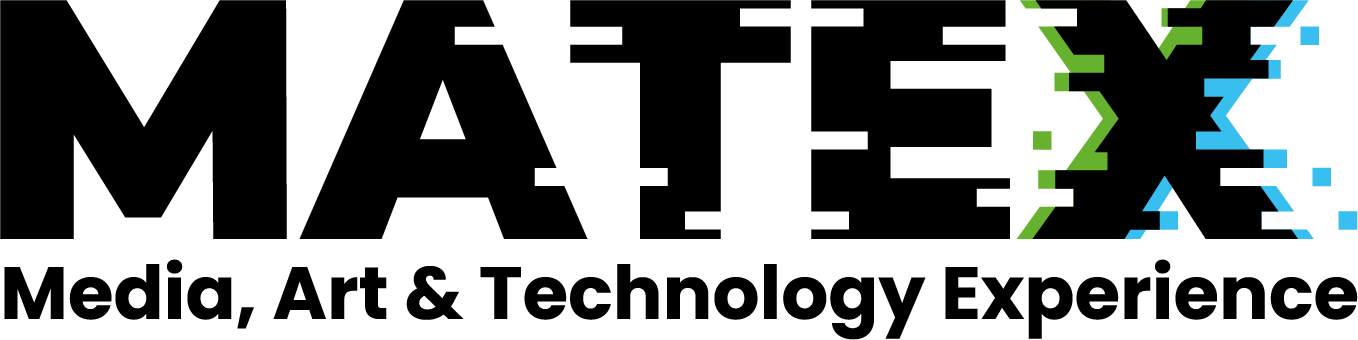(Federica Cannas) – Una porta vuota, due pali e una traversa. Un rettangolo di prato che per tutti è solo un pezzo di campo, ma per il portiere è un territorio esistenziale. È il luogo in cui il tempo si dilata e si contrae, in cui la solitudine diventa una compagna fedele e crudele. Il portiere non ha un avversario, ne ha undici, più lo stadio intero, più il destino.
La sua è una solitudine che non assomiglia a nessun’altra nello sport. È fatta di minuti interminabili in cui il gioco si svolge lontano, e lui resta lì, immobile, eppure teso come un filo elettrico. Poi, in un lampo, arriva il momento decisivo. Un tiro, un rigore, un colpo di testa. E tutta la partita si decide in quell’attimo.
Dino Zoff ha rappresentato la solitudine del portiere con la calma di chi non ha bisogno di gesti plateali. Non cercava la scena, non si agitava mai. Nel 1982, a quarant’anni, quando solleva la Coppa del Mondo al Bernabéu, ha il volto di un uomo che ha compiuto il proprio dovere fino in fondo. La sua grandezza stava nella capacità trasformare la solitudine in disciplina, in controllo assoluto, in presenza rassicurante. Era un muro silenzioso, capace di rendere meno pesante la paura dei compagni, e di far sembrare naturale l’impossibile.
Buffon, a Berlino nel 2006, è la solitudine che diventa leggenda. Zidane colpisce di testa, il pallone sembra imparabile. Buffon si alza in volo e con una mano lo devia sopra la traversa. L’Italia trattiene il respiro, Buffon rimane immobile dopo il volo. In quell’istante un’intera nazione è sospesa sul filo del sogno.
E poi c’è Gigio Donnarumma. Finale di Euro 2020, a Wembley, nel 2021, l’Inghilterra in casa, la pressione immensa. Quando para il rigore decisivo di Saka, non esulta. Non si rende conto che l’Italia è campione d’Europa. Rimane fermo, quasi smarrito, come se la solitudine lo avesse isolato anche dalla festa. Quell’immagine dice più di mille sorrisi. Il portiere è talmente abituato a pensarsi solo contro tutti, che fatica persino a riconoscere il momento in cui ha vinto.
Zoff che alza la coppa senza enfasi, Buffon che vola su Zidane, Donnarumma che non sorride. Sono fotografie diverse dello stesso destino. Il portiere non gioca mai soltanto una partita, ma una sfida più grande, che riguarda la fragilità. Deve convivere con l’idea che l’errore lo marchierà più delle parate. Deve accettare che la gloria sia effimera e la colpa eterna.
È un ruolo crudele, ma proprio per questo affascinante. Perché dentro quei guanti c’è la filosofia dell’attesa, l’arte del silenzio, la capacità di trasformare la solitudine in resistenza.
La solitudine del portiere assomiglia alla nostra. Tutti, prima o poi, ci ritroviamo davanti a una porta invisibile: nessuno dietro di noi, nessun appiglio, solo la responsabilità di difendere ciò che conta. È allora che comprendiamo fino in fondo cosa significhi essere soli, sapere che l’esito dipende soltanto da noi.
Forse è per questo che i portieri ci affascinano più di chiunque altro. Perchè ci ricordano che la vita è fatta di attimi decisivi, simili a rigori da parare. E che, anche quando sembra impossibile opporsi al destino, basta un gesto istintivo, un salto disperato e preciso, per cambiare tutto.
La sua è una solitudine che non assomiglia a nessun’altra nello sport. È fatta di minuti interminabili in cui il gioco si svolge lontano, e lui resta lì, immobile, eppure teso come un filo elettrico. Poi, in un lampo, arriva il momento decisivo. Un tiro, un rigore, un colpo di testa. E tutta la partita si decide in quell’attimo.
Dino Zoff ha rappresentato la solitudine del portiere con la calma di chi non ha bisogno di gesti plateali. Non cercava la scena, non si agitava mai. Nel 1982, a quarant’anni, quando solleva la Coppa del Mondo al Bernabéu, ha il volto di un uomo che ha compiuto il proprio dovere fino in fondo. La sua grandezza stava nella capacità trasformare la solitudine in disciplina, in controllo assoluto, in presenza rassicurante. Era un muro silenzioso, capace di rendere meno pesante la paura dei compagni, e di far sembrare naturale l’impossibile.
Buffon, a Berlino nel 2006, è la solitudine che diventa leggenda. Zidane colpisce di testa, il pallone sembra imparabile. Buffon si alza in volo e con una mano lo devia sopra la traversa. L’Italia trattiene il respiro, Buffon rimane immobile dopo il volo. In quell’istante un’intera nazione è sospesa sul filo del sogno.
E poi c’è Gigio Donnarumma. Finale di Euro 2020, a Wembley, nel 2021, l’Inghilterra in casa, la pressione immensa. Quando para il rigore decisivo di Saka, non esulta. Non si rende conto che l’Italia è campione d’Europa. Rimane fermo, quasi smarrito, come se la solitudine lo avesse isolato anche dalla festa. Quell’immagine dice più di mille sorrisi. Il portiere è talmente abituato a pensarsi solo contro tutti, che fatica persino a riconoscere il momento in cui ha vinto.
Zoff che alza la coppa senza enfasi, Buffon che vola su Zidane, Donnarumma che non sorride. Sono fotografie diverse dello stesso destino. Il portiere non gioca mai soltanto una partita, ma una sfida più grande, che riguarda la fragilità. Deve convivere con l’idea che l’errore lo marchierà più delle parate. Deve accettare che la gloria sia effimera e la colpa eterna.
È un ruolo crudele, ma proprio per questo affascinante. Perché dentro quei guanti c’è la filosofia dell’attesa, l’arte del silenzio, la capacità di trasformare la solitudine in resistenza.
La solitudine del portiere assomiglia alla nostra. Tutti, prima o poi, ci ritroviamo davanti a una porta invisibile: nessuno dietro di noi, nessun appiglio, solo la responsabilità di difendere ciò che conta. È allora che comprendiamo fino in fondo cosa significhi essere soli, sapere che l’esito dipende soltanto da noi.
Forse è per questo che i portieri ci affascinano più di chiunque altro. Perchè ci ricordano che la vita è fatta di attimi decisivi, simili a rigori da parare. E che, anche quando sembra impossibile opporsi al destino, basta un gesto istintivo, un salto disperato e preciso, per cambiare tutto.